Perché dimentichiamo i libri che leggiamo? La risposta, secondo la filosofia
di Edoardo Ciotola per Forum Agricoltura Sociale
Chiunque ami la lettura conosce quella sensazione: terminare un libro, sentirsi arricchiti, convinti di aver vissuto un'esperienza profonda e, dopo qualche mese, rendersi conto di ricordarne appena la trama o pochi dettagli. Questo fenomeno, tutt'altro che raro, è stato al centro di una riflessione che intreccia filosofia, psicologia e pratica della lettura. Giovanni Joja Chelli, appassionato di storia e letteratura, ha affrontato il tema in un video su TikTok, citando le idee del filosofo americano Mortimer Adler, autore del celebre saggio How to Mark a Book, pubblicato nel 1940.
Memoria e lettura: perché i libri svaniscono dalla mente. Dimenticare un libro, anche se appassionante, non significa non averne tratto beneficio. La memoria non funziona come un archivio statico, ma come un processo dinamico che seleziona, rielabora e spesso lascia andare ciò che non viene rinforzato. La filosofia della lettura invita a considerare che il vero valore di un testo non risieda solo nella capacità di ricordarne i dettagli, ma nell'impatto che ha sul pensiero e sulle connessioni che stimola. Adler sottolineava come il lettore passivo, che scorre le pagine senza interagire con esse, sia destinato a ricordare poco. Al contrario, chi dialoga con il libro, annotando, criticando e rielaborando, costruisce ricordi più solidi.
L'approccio di Mortimer Adler: i libri non sono oggetti sacri. Nel suo saggio, Adler spiegava che molte persone trattano i libri come reliquie intoccabili. Non li vogliono rovinare, non ci scrivono sopra, non li evidenziano. Questa convinzione, apparentemente rispettosa, in realtà crea distanza. Il filosofo sosteneva che un libro non va venerato, ma vissuto. Scrivere a margine, sottolineare un passaggio, segnare con la penna una riflessione, significa appropriarsi delle parole e renderle parte della propria identità intellettuale.
Secondo Adler, l’uso della matita è persino controproducente, perché lascia intendere la possibilità di cancellare ciò che si è pensato in quel momento. Per lui, invece, la lettura era un atto definitivo, un confronto serio che meritava la permanenza delle annotazioni. Detto in altri termini: bisogna avere un approccio egoistico e non pensare che "magari potremmo prestarlo a qualcuno".
I libri come specchio del percorso personale. Ogni volume annotato diventa un documento privato, un testimone del periodo in cui è stato letto. Riprenderlo in mano anni dopo non significa solo rileggere quelle pagine, ma tornare al confronto che si era instaurato con esse. Quelle note, quelle sottolineature, raccontano chi eravamo, quali dubbi avevamo e quali convinzioni stavamo costruendo. In questo senso, Adler invitava a non vendere mai i propri libri annotati, perché rappresentano un pezzo irripetibile del proprio percorso di crescita. Il lettore che sottolinea e scrive dialoga con l'autore, stabilendo un legame che non può essere replicato con un volume "pulito".
Dal gesto pratico alla filosofia della memoria. Il suggerimento di Adler non è soltanto pratico, ma filosofico. Egli riteneva che l'atto di scrivere nei libri avesse un valore educativo e formativo, capace di trasformare la lettura da esperienza passiva a esercizio critico. Questo spiega perché molti lettori dimenticano ciò che hanno letto: non hanno mai trasformato il contenuto in pensiero personale. La memoria, infatti, non conserva solo ciò che viene esposto, ma soprattutto ciò che viene elaborato attivamente. Così, evidenziare una frase o annotare un commento equivale a imprimere un segno non solo sulla carta, ma anche nella mente. Un libro annotato diventa allora un ponte tra passato e presente, una traccia tangibile del dialogo interiore che accompagna ogni lettura.
Rileggere, sottolineare, criticare, scrivere a margine: queste azioni non eliminano l'oblio, ma lo trasformano. Non ricordiamo tutto, e forse non dobbiamo farlo, ma possiamo costruire un rapporto duraturo con ciò che leggiamo, lasciando che ogni libro entri a far parte della nostra identità intellettuale.

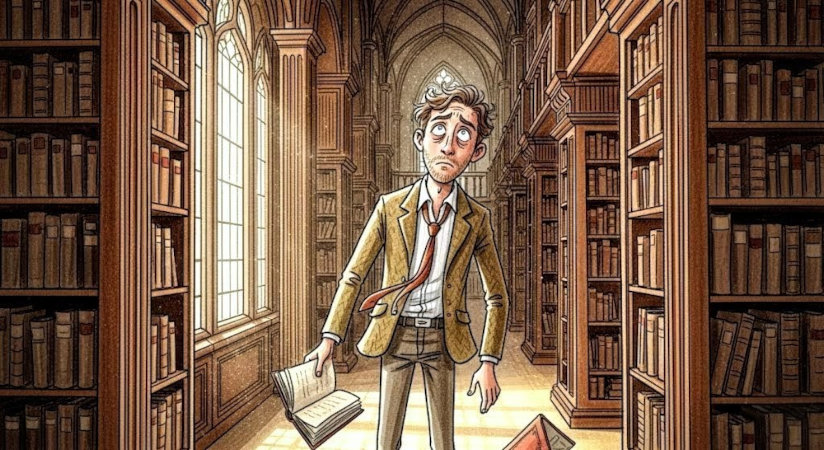
Nessun commento:
Posta un commento